
La città
San Ruggiero o San Ruggero? Mettiamo i puntini sulla "i"
Domenico Vischi interroga gli studiosi dell'Accademia della Crusca che rispondono al quesito
Barletta - sabato 30 dicembre 2017
Comunicato Stampa
Il cittadino Domenico Vischi ha effettuato diversi studi circa il nome del Santo Patrono di Barletta: si chiamava Ruggero, oppure Ruggiero? L'articolo inviato consiste nel testo che ha trasmesso quest'ultimo all'Accademia della Crusca, e nella relativa risposta che ne ha ricevuto.
«Spett.li Dirigenti e Studiosi dell' Accademia della Crusca, da giornalista, e prima ancora da cittadino e cattolico, con la presente sono a porvi un quesito che nella mia Barletta ha impegnato per anni gli storici locali, in uno ai canonici ed alla immancabile "politica". Il quesito attiene alla "più corretta" menzione del Santo Patrono della Città di Barletta: bisogna chiamarlo San Ruggiero (con la "i"), oppure San Ruggero (senza la "i")? Non si tratta di una questione di lana caprina: sul punto a Barletta si è polemizzato aspramente per anni. E la polemica si è acuita da qualche anno a questa parte.
In premessa è necessario riferire che il 99% dei miei concittadini che portano il nome del Santo Patrono, si chiamano "RUGGIERO". La versione "senza la i", largamente maggioritaria nel resto d'Italia, è invece pressoché inesistente a Barletta. Il problema è sorto allorquando l'ex arcivescovo della Diocesi di Trani (curia che, a seguito della riforma del 1986, ha assorbito l'antica "Diocesi di Barletta, Canne della Battaglia e Nazareth", per secoli insediata nella Città della Disfida) ha inteso "omologare" Barletta al resto d'Italia. Per il prelato, non era ammissibile che solo a Barletta si dovesse fare eccezione rispetto alla generalità dei casi italiani, che disconoscevano la versione "con la i", ed adottavano a tappeto il nome RUGGERO. Prelato che banalizzava la versione barlettana (RUGGIERO) bollandola come "un errore di traduzione dal latino; un errore grammaticale; una tradizione barlettana (probabilmente di origine vernacolare) che non ha riscontro alcuno nelle fonti antiche; una trascrizione in anagrafe e/o nei registri di battesimo affetta da refuso, che si è tramandato nei secoli...". Non potendo l'ex vescovo (adesso banalizzo io!!) ordinare a tutti di correggere il "refuso" in anagrafe e nei certificati di battesimo, si è limitato a diramare un comunicato ufficiale della Curia: "l nome ufficiale del Santo Patrono di Barletta, riconosciuto dalla Chiesa cattolica, è San RUGGERO". E da quel momento non c'è manifesto, pubblicazione, articolo di giornale, evento ufficiale, celebrazione... in cui la versione ufficiale (Ruggero) non sia sbandierata, e la versione "barlettana" non sia ridicolizzata come frutto di ignoranza della plebaglia!
Rispetto a detta banalizzazione dell'ex arcivescovo, io mi pongo in netto contrasto. Ritengo che ambo le versioni (con la "i", oppure senza) siano ammissibili, e parimenti corrette. Non vi è una versione più appropriata dell'altra; non esiste una traduzione dal latino più corretta dell'altra, (ammesso e non concesso, come vedremo, che la stella polare da seguire sia il latino ROGERIUS). Anzi, per motivi storici e territoriali, ritengo che dovendo fare una scelta fra le due versioni, quella più rispondente alla realtà sia proprio la versione barlettana, ossia RUGGIERO. Il prelato parte dall'assunto - per me sbagliato - che la corretta traduzione in italiano del nome in latino ROGERIUS, non possa che essere RUGGERO. Poiché - a suo intendere - sarebbe grammaticalmente scorretto frapporre tra la "g" e la "e" una lettera "i", assolutamente superflua dal punto di vista fonetico. Su tale considerazione sbrigativa del prelato, mi limito a fornire un solo esempio che dimostra l'opposto: il sostantivo RAGGIERA (fascio di raggi che hanno origine in un solo punto). Anche la resa fonetica nel suo complesso appare piuttosto simile a RUGGIERO.
Rispetto al Santo Patrono di Barletta è bene allegare una piccola nota storica:
San Ruggiero, vescovo di Canne (Canne, 1060 - Canne, 30 dicembre 1129) fu un vescovo italiano; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. La località (della celeberrima Canne della Battaglia) in cui nacque S. Ruggiero fu "Torre Pietra", nell'agro dell'odierna Margherita di Savoia (BT), già "Saline di Barletta". Ruggiero fu eletto vescovo della città di Canne, dove era sorta una piccola diocesi già dal X secolo. Si trovò così a reggere le sorti della sua città natale, reduce della dolorosa distruzione voluta nel 1083 dai Normanni, ad opera di Roberto il Guiscardo. Ruggiero contribuì alla ricostruzione morale e materiale dell'antica città pugliese, sostenendo i suoi concittadini con i conforti della fede e con l'aiuto materiale.
San Ruggiero si colloca in quella lista di santi che hanno segnato il rinnovamento della Chiesa tra XI e XII secolo. L'esigenza di riforma fu l'indirizzo del pontificato di san Gregorio VII: ritornare alla vita evangelica delle origini e riottenere l'indipendenza della Chiesa dal potere temporale. Ruggiero concepisce l'episcopato come servizio e non come uno strumento per arrivare al prestigio. L'Anonimo Cannese, antica fonte biografica locale del XIV secolo ci rivela alcuni aspetti della personalità di Ruggiero: «Era assai pietoso et fervoroso per la salute delle anime il suo episcopio era un puro hospitio che sempre stava aperto de nocte et de giorno ad alloggiare le viandanti et le pellegrini, et le viude et li pupilli dove trovavano le loro conforto et le loro consolazioni. Andava scalzo con lo pede nudo per quelle campagne cercanno le limosine per li poveri».
Dai documenti dell'epoca risulta che il santo vescovo fu più volte interpellato dai pontefici Pasquale II e Gelasio II per dirimere alcune questioni di diritto, per comporre liti e placare rivalità tra ecclesiastici e comunità: questo ci attesta la stima che godeva tra i contemporanei. Nel settembre 1101 fu presente alla consacrazione della cattedrale di san Sabino a Canosa. Morì il 30 dicembre 1129. Fu acclamato subito santo e il suo corpo fu adagiato presso l'altare maggiore della cattedrale di Canne. Già da un documento del 1192 risulta a Canne una località detta Locus Sancti Rogerii: si tratta, con molta probabilità del luogo in cui è sita una fonte (ancora oggi esistente) fatta scaturire in un duro momento di siccità - secondo la tradizione locale - da san Ruggiero, che percosse la roccia con il bastone pastorale. A motivo della repentina decadenza di Canne, il popolo e il vescovo si rifugiarono nella vicina Barletta. Anche le venerate spoglie di San Ruggiero furono traslate a Barletta il giorno 27 aprile 1276, dapprima nella cattedrale di Santa Maria Maggiore e più tardi presso la chiesa del monastero delle benedettine celestine di Santo Stefano (che poi si chiamerà "di San Ruggiero"). Le reliquie, dapprima custodite sotto l'altare maggiore della chiesa monastica, furono collocate in una nuova urna d'argento fatta realizzare nel 1929. Nel 1996 fu eseguita la ricognizione canonica sulle reliquie; esse poi, unitamente al cranio (precedentemente conservato nel busto-reliquiario), furono disposte in una più ampia e confortevole teca, che trova la sua collocazione attuale sotto la nuova mensa della chiesa.
Il primo documento (posteriore a quello del 1192) che attesta la fama di santità di Ruggiero è una pergamena del 1327 recante il sigillo del vescovo cannese Pascalis: esso riproduce l'immagine di San Ruggiero (con la scritta S.TUS ROG.US) con il capo circondato da una aureola. La sua memoria liturgica cade il 30 dicembre, così come riportato dal Martirologio Romano. Iconografia: San Ruggiero è sempre rappresentato in abiti pontificali da vescovo, con mitria e pastorale. È sempre sormontato da un'aquila in volo che - secondo un'antica leggenda - lo avrebbe adombrato con le sue ali in una caldissima giornata estiva, mentre era in pellegrinaggio al Gargano verso la Basilica dell'Arcangelo San Michele. Va messo in evidenza che il Santo Vescovo di Canne è l'UNICO San Ruggiero (o Ruggero, Roger... che dir si voglia) di tutta la cristianità! In 2000 anni di cristianesimo non si è avuto altro Santo con tale nome (anche al femminile), in nessuna parte del mondo. Altri uomini pii sono stati riconosciuti dalla Chiesa solo "Beati", o "Venerabili" (ad es., il Beato Ruggero da Todi, francescano del XIII secolo).
Dal mio punto di vista, la tesi massimalista dell'ex Vescovo di Trani trova smentita anche nella stessa origine del nome di persona RUGGERO, o RUGGIERO. Riporto alcune nozioni rinvenute sul web. "Ruggero" è un nome proprio di persona italiano maschile. Varianti maschili: Ruggiero, Roggero, Ruggeri. Varianti femminili: Ruggera, Ruggerina. Varianti in altre lingue:
Anglosassone: Hroðgar, Hrothgar.
Francese: Roger.
Germanico: Hrodger.
Greco moderno: Ρογήρος (Rogīros).
Inglese: Roger, Rodger; Ipocoristici: Rodge.
Islandese: Hróðgeir.
Lussemburghese: Rutger; Ipocoristici: Ruth.
Olandese: Rutger, Rogier, Rogiër.
Norreno: Hróðgeirr.
Polacco: Roger.
Portoghese: Rogério.
Svedese: Roger.
Tedesco: Rüdiger, Rutger, Roger.
«Spett.li Dirigenti e Studiosi dell' Accademia della Crusca, da giornalista, e prima ancora da cittadino e cattolico, con la presente sono a porvi un quesito che nella mia Barletta ha impegnato per anni gli storici locali, in uno ai canonici ed alla immancabile "politica". Il quesito attiene alla "più corretta" menzione del Santo Patrono della Città di Barletta: bisogna chiamarlo San Ruggiero (con la "i"), oppure San Ruggero (senza la "i")? Non si tratta di una questione di lana caprina: sul punto a Barletta si è polemizzato aspramente per anni. E la polemica si è acuita da qualche anno a questa parte.
In premessa è necessario riferire che il 99% dei miei concittadini che portano il nome del Santo Patrono, si chiamano "RUGGIERO". La versione "senza la i", largamente maggioritaria nel resto d'Italia, è invece pressoché inesistente a Barletta. Il problema è sorto allorquando l'ex arcivescovo della Diocesi di Trani (curia che, a seguito della riforma del 1986, ha assorbito l'antica "Diocesi di Barletta, Canne della Battaglia e Nazareth", per secoli insediata nella Città della Disfida) ha inteso "omologare" Barletta al resto d'Italia. Per il prelato, non era ammissibile che solo a Barletta si dovesse fare eccezione rispetto alla generalità dei casi italiani, che disconoscevano la versione "con la i", ed adottavano a tappeto il nome RUGGERO. Prelato che banalizzava la versione barlettana (RUGGIERO) bollandola come "un errore di traduzione dal latino; un errore grammaticale; una tradizione barlettana (probabilmente di origine vernacolare) che non ha riscontro alcuno nelle fonti antiche; una trascrizione in anagrafe e/o nei registri di battesimo affetta da refuso, che si è tramandato nei secoli...". Non potendo l'ex vescovo (adesso banalizzo io!!) ordinare a tutti di correggere il "refuso" in anagrafe e nei certificati di battesimo, si è limitato a diramare un comunicato ufficiale della Curia: "l nome ufficiale del Santo Patrono di Barletta, riconosciuto dalla Chiesa cattolica, è San RUGGERO". E da quel momento non c'è manifesto, pubblicazione, articolo di giornale, evento ufficiale, celebrazione... in cui la versione ufficiale (Ruggero) non sia sbandierata, e la versione "barlettana" non sia ridicolizzata come frutto di ignoranza della plebaglia!
Rispetto a detta banalizzazione dell'ex arcivescovo, io mi pongo in netto contrasto. Ritengo che ambo le versioni (con la "i", oppure senza) siano ammissibili, e parimenti corrette. Non vi è una versione più appropriata dell'altra; non esiste una traduzione dal latino più corretta dell'altra, (ammesso e non concesso, come vedremo, che la stella polare da seguire sia il latino ROGERIUS). Anzi, per motivi storici e territoriali, ritengo che dovendo fare una scelta fra le due versioni, quella più rispondente alla realtà sia proprio la versione barlettana, ossia RUGGIERO. Il prelato parte dall'assunto - per me sbagliato - che la corretta traduzione in italiano del nome in latino ROGERIUS, non possa che essere RUGGERO. Poiché - a suo intendere - sarebbe grammaticalmente scorretto frapporre tra la "g" e la "e" una lettera "i", assolutamente superflua dal punto di vista fonetico. Su tale considerazione sbrigativa del prelato, mi limito a fornire un solo esempio che dimostra l'opposto: il sostantivo RAGGIERA (fascio di raggi che hanno origine in un solo punto). Anche la resa fonetica nel suo complesso appare piuttosto simile a RUGGIERO.
Rispetto al Santo Patrono di Barletta è bene allegare una piccola nota storica:
San Ruggiero, vescovo di Canne (Canne, 1060 - Canne, 30 dicembre 1129) fu un vescovo italiano; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. La località (della celeberrima Canne della Battaglia) in cui nacque S. Ruggiero fu "Torre Pietra", nell'agro dell'odierna Margherita di Savoia (BT), già "Saline di Barletta". Ruggiero fu eletto vescovo della città di Canne, dove era sorta una piccola diocesi già dal X secolo. Si trovò così a reggere le sorti della sua città natale, reduce della dolorosa distruzione voluta nel 1083 dai Normanni, ad opera di Roberto il Guiscardo. Ruggiero contribuì alla ricostruzione morale e materiale dell'antica città pugliese, sostenendo i suoi concittadini con i conforti della fede e con l'aiuto materiale.
San Ruggiero si colloca in quella lista di santi che hanno segnato il rinnovamento della Chiesa tra XI e XII secolo. L'esigenza di riforma fu l'indirizzo del pontificato di san Gregorio VII: ritornare alla vita evangelica delle origini e riottenere l'indipendenza della Chiesa dal potere temporale. Ruggiero concepisce l'episcopato come servizio e non come uno strumento per arrivare al prestigio. L'Anonimo Cannese, antica fonte biografica locale del XIV secolo ci rivela alcuni aspetti della personalità di Ruggiero: «Era assai pietoso et fervoroso per la salute delle anime il suo episcopio era un puro hospitio che sempre stava aperto de nocte et de giorno ad alloggiare le viandanti et le pellegrini, et le viude et li pupilli dove trovavano le loro conforto et le loro consolazioni. Andava scalzo con lo pede nudo per quelle campagne cercanno le limosine per li poveri».
Dai documenti dell'epoca risulta che il santo vescovo fu più volte interpellato dai pontefici Pasquale II e Gelasio II per dirimere alcune questioni di diritto, per comporre liti e placare rivalità tra ecclesiastici e comunità: questo ci attesta la stima che godeva tra i contemporanei. Nel settembre 1101 fu presente alla consacrazione della cattedrale di san Sabino a Canosa. Morì il 30 dicembre 1129. Fu acclamato subito santo e il suo corpo fu adagiato presso l'altare maggiore della cattedrale di Canne. Già da un documento del 1192 risulta a Canne una località detta Locus Sancti Rogerii: si tratta, con molta probabilità del luogo in cui è sita una fonte (ancora oggi esistente) fatta scaturire in un duro momento di siccità - secondo la tradizione locale - da san Ruggiero, che percosse la roccia con il bastone pastorale. A motivo della repentina decadenza di Canne, il popolo e il vescovo si rifugiarono nella vicina Barletta. Anche le venerate spoglie di San Ruggiero furono traslate a Barletta il giorno 27 aprile 1276, dapprima nella cattedrale di Santa Maria Maggiore e più tardi presso la chiesa del monastero delle benedettine celestine di Santo Stefano (che poi si chiamerà "di San Ruggiero"). Le reliquie, dapprima custodite sotto l'altare maggiore della chiesa monastica, furono collocate in una nuova urna d'argento fatta realizzare nel 1929. Nel 1996 fu eseguita la ricognizione canonica sulle reliquie; esse poi, unitamente al cranio (precedentemente conservato nel busto-reliquiario), furono disposte in una più ampia e confortevole teca, che trova la sua collocazione attuale sotto la nuova mensa della chiesa.
Il primo documento (posteriore a quello del 1192) che attesta la fama di santità di Ruggiero è una pergamena del 1327 recante il sigillo del vescovo cannese Pascalis: esso riproduce l'immagine di San Ruggiero (con la scritta S.TUS ROG.US) con il capo circondato da una aureola. La sua memoria liturgica cade il 30 dicembre, così come riportato dal Martirologio Romano. Iconografia: San Ruggiero è sempre rappresentato in abiti pontificali da vescovo, con mitria e pastorale. È sempre sormontato da un'aquila in volo che - secondo un'antica leggenda - lo avrebbe adombrato con le sue ali in una caldissima giornata estiva, mentre era in pellegrinaggio al Gargano verso la Basilica dell'Arcangelo San Michele. Va messo in evidenza che il Santo Vescovo di Canne è l'UNICO San Ruggiero (o Ruggero, Roger... che dir si voglia) di tutta la cristianità! In 2000 anni di cristianesimo non si è avuto altro Santo con tale nome (anche al femminile), in nessuna parte del mondo. Altri uomini pii sono stati riconosciuti dalla Chiesa solo "Beati", o "Venerabili" (ad es., il Beato Ruggero da Todi, francescano del XIII secolo).
Dal mio punto di vista, la tesi massimalista dell'ex Vescovo di Trani trova smentita anche nella stessa origine del nome di persona RUGGERO, o RUGGIERO. Riporto alcune nozioni rinvenute sul web. "Ruggero" è un nome proprio di persona italiano maschile. Varianti maschili: Ruggiero, Roggero, Ruggeri. Varianti femminili: Ruggera, Ruggerina. Varianti in altre lingue:
Anglosassone: Hroðgar, Hrothgar.
Francese: Roger.
Germanico: Hrodger.
Greco moderno: Ρογήρος (Rogīros).
Inglese: Roger, Rodger; Ipocoristici: Rodge.
Islandese: Hróðgeir.
Lussemburghese: Rutger; Ipocoristici: Ruth.
Olandese: Rutger, Rogier, Rogiër.
Norreno: Hróðgeirr.
Polacco: Roger.
Portoghese: Rogério.
Svedese: Roger.
Tedesco: Rüdiger, Rutger, Roger.
Origine e diffusione:
Deriva dal nome germanico Hrodger o Hrotger che, composto dai termini hrod o hruod ("fama", "gloria") e ger ("lancia"), può essere tradotto come "lancia gloriosa" o "famoso con la lancia" o, per estensione, "guerriero famoso". I normanni lo portarono in Inghilterra, dove rimpiazzò il nome imparentato Hroðgar (nome di un leggendario re citato nel Beowulf). Il nome norvegese Roar può essere una variante di Ruggero, tuttavia la sua etimologia ha diverse interpretazioni. Non va invece confuso col nome spagnolo Rogelio, che ha origine differente, sebbene i due vengano occasionalmente accostati. Documentato sin dalla fine del IX secolo nelle forme latinizzate Rotecherius, Rotgerius e Rogerius, il nome Ruggero venne introdotto in Italia attorno all'anno 1000 attraverso il francese antico Rogier. La sua diffusione è dovuta anche ai sovrani normanni con questo nome che governarono e conquistarono la Sicilia nell'XI secolo. Attualmente è accentrato al Nord, mentre la forma Ruggiero è diffusa in Campania, in Puglia e in Sicilia, e Roggero è tipico del Piemonte. Al di fuori dell'Italia, il nome è particolarmente diffuso in Francia e in Inghilterra, dov'è noto nella forma Roger; anche in quest'ultimo Paese venne portato dai normanni, e durante il Medioevo divenne molto comune; al XVIII secolo il suo uso si era rarificato, ma venne ripreso negli anni seguenti.
A ben guardare, nel periodo storico in cui visse il Santo vescovo di Canne (XI secolo) e subito dopo, la versione "con la i" era frequente non meno di quella "senza la i". Si possono fare alcuni esempi, non distanti dall'XI secolo.
- Ruggiero di Lauria o Ruggiero dell'Oria (nato il 1245), ammiraglio.
- Ruggiero Amico, (nato il 1248), giustiziere ai tempi di Federico II di Svevia ed esponente della Scuola poetica siciliana.
- Ruggiero Calcagni, (nato intorno al 1200), predicatore domenicano.
Indicato nelle fonti storiche anche come "Roggerius o Rogerius de Calcagnis", ma anche come "Roggierus Calcagninus". In merito alla versione "Roggierus Calcagninus", ne ho verificato personalmente l'attendibilità nel "Catalogus Scriptorum Florentinorum". Detto testo, alla pagina 172 riporta "Roggierus Calcagninus, Dominicanus", (Ruggiero Calcagni, sacerdote domenicano).v. 13-15). Non meno rilevante, dal mio punto di vista, è la presenza di RUGGIERO anche come "cognome".
Infatti, i cognomi derivano in larga parte dalla necessità (sorta intorno all'anno mille, con la ripresa dell'inurbamento delle masse) di individuare una persona con assoluta precisione nell'estensione dei rogiti notarili. E la modalità più usata e più pratica di ricavare un cognome era servirsi della "paternità" (più raramente, della maternità). Va da sé che i cognomi del tipo "Ruggiero, Ruggieri, Di Ruggiero, De Ruggiero... ecc..." derivano da avi/patriarchi che si chiamavano esattamente RUGGIERO. Un caso emblematico: Trotula de Ruggiero, vissuta proprio nell'XI secolo. Esponente donna della Scuola Medica Salernitana. Si chiamò Trotula de Ruggiero (1050 - 1097) uno dei medici donna nella storia italiana. E forse fu una delle prime donne medico. Misteriose potrebbero essere le prime tracce del suo lavoro che parte dallo studio dei rimedi naturali. Misterioso così anche il suo nome che in alcuni testi diventa Trottula, oppure Trotta, e ancora Trocta; per alcuni semplicemente Trota De Ruggiero. E in Salerno dove esercitò la "professione" il suo cognome era molto diffuso allora, come lo è ancora oggi.
La permanenza del nome proprio RUGGIERO anche nei secoli successivi è attestata da moltissime fonti. In questa sede mi limito a citare il celeberrimo Paladino (convertito al cristianesimo) "Ruggiero", de "L'Orlando Furioso" di Ludovico Ariosto, pubblicato il 1516. La presenza di un RUGGIERO nel poema cavalleresco, a mio modesto avviso, è indice di alcuni dati da non sottovalutare. Ancora nel 1500 il nome "Ruggiero" era diffuso in tutta Italia, non meno della versione "senza i". Essendo detto poema cavalleresco afferente al periodo storico di Carlo Magno (VIII-IX secolo), non è peregrino ritenere che L. Ariosto (diversamente da Boiardo) abbia utilizzato il nome RUGGIERO essendo in possesso di fonti documentali in grado di attestare che fra i carolingi "italiani" ("italiani" fra molte virgolette) di alto lignaggio e fra i cavalieri, il nome RUGGIERO (con la i) era diffuso. In fondo (con o senza la "i"), la traduzione del nome dalla lingua germanica è "lancia gloriosa": ciò fa di "Ruggiero" il nome e l'appellativo più consono per un uomo d'armi, un paladino! La scelta di Ariosto di chiamare RUGGIERO il suo paladino, differenziandosi da Boiardo che aveva chiamato RUGGERO lo stesso cavaliere, un significato "storico" lo deve pur avere.
Vi è anche la versione del nome proprio "con la i, e al plurale": Ruggieri. Del resto era in uso all'epoca utilizzare nomi che oggi noi definiremmo "al plurale": Manfredi, Tancredi... Alcuni esempi: - Ruggieri Apuliese (vissuto il 1260), poeta italiano. - Ruggieri degli Ubaldini (morto il 15 settembre 1295), arcivescovo cattolico italiano. Ne parla Dante nella Commedia (Inferno XXXIII) Dello stesso periodo è infine lo schema melodico che, senza dubbio, mutua il nome da un musico di nome Ruggiero (con la i). Il "Ruggiero", o "basso di Ruggiero", è uno schema melodico-armonico su basso ostinato molto popolare in Europa fra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Settecento, impiegato in numerose composizioni sia vocali che strumentali. A questo punto abbiamo nozioni sufficienti per trarre delle conclusioni appropriate. Il volgare italico esisteva da ben prima dell'anno mille. Quindi non può ritenersi che gli italici parlassero ancora il latino, come era norma almeno fino all'VIII secolo. Il latino era ancora in uso fra i chierici, i giuristi, i burocrati, gli uomini di scienza ed i colti in genere, e la nobiltà. Ma fra il volgo non vi era più l'abitudine ad esprimersi in latino. Il "Placito Capuano" (sentenza di un Giudice afferente il possesso trentennale di terreni agricoli, datata 960 d.C.) è il primo atto ufficiale (rinvenuto) contenente una testimonianza resa e verbalizzata in volgare italico. Cosa comporta questa considerazione rispetto all'argomento da me trattato? Secondo me, il portato del Placito Capuano è rilevantissimo ai fini di cui ad oggetto. Se un Giudice codifica una testimonianza "in volgare italico" e non in latino (la lingua del diritto), significa che il volgare ormai da secoli non era più considerato un mero dialetto, ma aveva assunto la dignità di lingua ufficiale (o quasi ufficiale). E di sicuro era la sola lingua in cui le masse si sapevano esprimere.
La considerazione testè riportata riguardo alla intervenuta desuetudine del latino presso il volgo già prima dell'anno 1000, è molto più vera per quanto riguarda i nomi propri di persona. A differenza delle lingue, delle relative regole grammaticali e dei vocaboli, i nomi propri di persona variano molto nel corso del tempo, perché non risentono di una rigorosa codificazione. Al contrario, risentono molto delle mode del tempo: un Santo molto venerato, un personaggio illustre... determinano nella contingenza una rapidissima diffusione di quel nome proprio. Con questo cosa intendo dire? Intendo sostenere che è assai dubbio che il nome proprio del Santo Patrono di Barletta sia stato espresso pro tempore "in latino". Dubito che nell'Italia dell'XI secolo vi fosse ancora la consuetudine di chiamare le persone con nomi "in latino". Ergo, il nostro Santo Patrono, probabilmente, era stato chiamato dai suoi genitori con una versione del nome "italianizzata", e non col nome latino ROGERIUS. Ed in tale versione "italiana" (ritengo, non dissimile da RUGGIERO) era chiamato e riconosciuto dai suoi contemporanei. Il nostro Santo è passato alla storia come ROGERIUS solo perché negli atti ufficiali civili ed ecclesiastici, come nella letteratura, il latino la farà da padrone almeno fino al XIII secolo; e solo con Dante si porrà seriamente la questione della dignità del volgare italico come lingua "eloquente" e di pari dignità rispetto al latino per la produzione letteraria.
Del resto si è argomentato in precedenza circa l'origine del nome RUGGIERO. Si è detto che tale nome non è di origine "latina". Non è neppure di origine "italica". È un nome "germanico", importato e diffuso in Italia da altri popoli: germani, normanni...Si è detto anche che il nome RUGGIERO è documentato sin dalla fine del IX secolo nelle forme latinizzate Rotecherius, Rotgerius e Rogerius, e venne introdotto in Italia attorno all'anno 1000 attraverso il francese antico "Rogier".
Ricapitalondo:
- Il nome RUGGIERO è un nome di origine germanica, non latina e/o italiana.
- Il nome fu introdotto in Italia nella versione in francese arcaico: Rogier. Fu latinizzato dopo.
- ROGERIUS è solo una delle forme "latinizzate" con cui ha avuto diffusione il nome: è UNA, non l'UNICA!
- Altra versione latinizzata è ROGGIERUS, molto ma molto simile a RUGGIERO.
- San Ruggiero era di Canne della Battaglia (ovvero di Barletta): è assai più probabile quindi che la tradizione (e la traduzione) che i barlettani osservano da secoli sia quella autentica. Perché dovrebbero serbare la verità coloro che sono di località lontane dal territorio natale del Santo Vescovo di Canne?
- Il nome, si ribadisce, venne introdotto in Italia attorno all'anno 1000, NON nella versione "latinizzata" ROGERIUS, ma nella versione in francese antico: Rogier.
- Il francese antico ROGIER, a mio avviso, è più simile a RUGGIERO che a RUGGERO.
- Nell'Italia dell'XI secolo è assai improbabile che le persone adottassero ancora nomi "in latino". Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.), un flusso continuo in Europa ed in Italia di popolazioni e tradizioni barbariche ha apportato una notevole varietà di nomi "sconosciuti" prima di allora. Nomi che, non avendo omologhi in lingua latina, venivano "latinizzati" ai fini dell'ufficialità civile e religiosa. Ma alle soglie dell'anno 1000 il volgare italico (pur nelle diverse sfaccettature localistiche) era ormai formato.
- Non resta che concludere che nell'XI secolo i nomi propri di persona erano comunemente espressi solo in volgare italico; per mero formalismo ed ufficialità dei rogiti notarili, delle sentenze, e dei registri civili ed ecclesiastici, i nomi propri venivano "tradotti in latino".
- Certamente la Chiesa, all'atto del battezzare continuava ad adottare la formula canonica in latino (ROGERIUS, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo...); ma nel parlare comune, è assai improbabile che il Santo Vescovo di Canne fosse chiamato ROGERIUS dai suoi genitori, o che venisse chiamato ROGERIUS dai suoi contemporanei cannesi. Ritengo più verosimile una versione in volgare italico: RUGGIERO (o qualcosa di simile).
- La mia tesi - che prende le mosse dal dato di fatto che il nome RUGGIERO nasca il lingua germanica, ed approdi in Italia nel francese antico ROGIER, e solo dopo venga latinizzato - è del tutto congruente con l'evoluzione storica che il nome ha avuto nei secoli, fino ai giorni nostri.
- La tesi "quantomeno frettolosa" del prelato emerito di Trani trova in tutti i dati su riportati un ostacolo insormontabile.
- Il nome proprio RUGGIERO (con la i) NON è una versione distorta e sgrammaticata di RUGGERO (vedi il sostantivo RAGGIERA); né può sostenersi che, eventualmente, ROGERIUS debba per forza tradursi in RUGGERO. Visto che tradurre un nome proprio è sempre sbagliato, tutte le traduzioni che possono farsi sono parimenti sbagliate. Ciò le rende TUTTE ARBITRARIAMENTE CORRETTE!! Del resto è stravagante che "Ianuarius" sia oggi tradotto in "San GENNARO"...
- RUGGIERO non è neppure una traduzione arbitraria ed erronea del nome latino ROGERIUS, visto che ROGERIUS non è l'unica versione latina del nome (vedi ROGGIERUS), nè la più corretta. E neppure avrebbe senso fondare tali proprie (apodittiche) convinzioni su un nome "germanico", introdotto in Italia in versione "francese arcaico", e solo dopo "latinizzato".
- L'esistenza del nome RUGGIERO (con la i) in tutte le epoche, in tutte le fonti documentali e letterarie, ed in tutte le aree geografiche (ed ancora oggi largamente in tutto il meridione d'Italia, e non solo a Barletta), dimostra che non si tratta di una bizzarrìa vernacolare barlettana - come falsamente ritenuto dal prelato».
La Dott.ssa Chiara Francalanci, della Redazione Consulenza Linguistica dell'Accademia della Crusca, in data 20 dicembre, trasmise a Domenico Vischi:
«Gentile sig. Domenico Vischi, il suo quesito non ha avuto risposta dalla nostra Redazione non solo per le ragioni che lei stesso riporta nella sua ultima lettera, ma soprattutto perché si tratta di una questione che merita uno studio approfondito e specifico che infatti lei ha iniziato ad affrontare. Questo in termini generali, mentre se si restringe il campo solo al nome del Santo, i dati che riporta dovrebbero essere validati da ricerche d'archivio e confronti con documenti antichi e la nostra Redazione non può svolgere questo tipo di servizio. Tenga conto, in ogni modo che, dal punto di vista linguistico, Ruggiero e Ruggero in italiano sono due varianti dello stesso nome, a prescindere dai personaggi, reali o letterari, cui è stato assegnato; inoltre nelle parlate dell'Italia meridionale è diffusa la pronuncia della i in contesti simili, anche quando non sia necessaria nella grafia (in questo caso c'è la e che garantisce la pronuncia affricata della g) e proprio questo può aver condizionato la resa grafica con la i che si è fissata nella scrittura anche attraverso documenti ecclesiastici e atti di battesimo. Sicuramente la forma Ruggiero non è una resa scorretta di Ruggero che si è tramandata attraverso errori o "refusi", semmai una forma arcaica che risente di influenze dialettali e che, proprio per questo, si è conservata più a lungo in alcune aree, resistendo alla generale tendenza all'uniformazione che ha portato alla prevalenza in italiano della forma Ruggero. Per verificare queste informazioni e per ulteriori approfondimenti può consultare l'ottimo dizionario storico ed etimologico I nomi di persona in Italia a cura di A. Rossebastiano e E. Papa (Torino, Utet, 2008)».

j.jpg)
.jpg)

j.jpg)
j.jpg)



 Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta 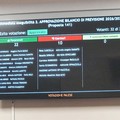


.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)

.jpg)


